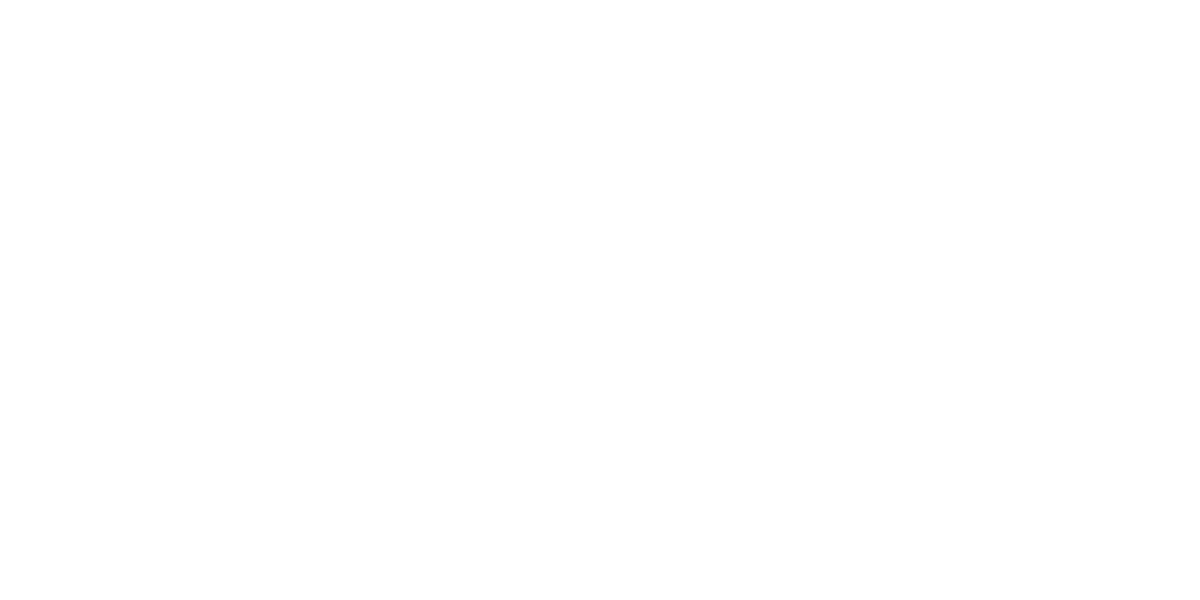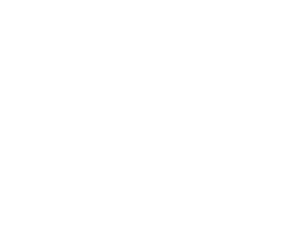Non è scandaloso che la Corte di Cassazione chieda al Tribunale di sorveglianza di Bologna maggiori lumi, e su quali elementi si fondi una sua decisione. Farlo è il suo mestiere. Scandaloso, semmai, se questa richiesta non ci fosse state. Non ha tutti i torti la Corte di Cassazione quando osserva che ferma restando “l’altissima pericolosità” e “e l’indiscusso spessore criminale” di Totò Riina, non si chiarisce tuttavia “come tale pericolosità possa e debba considerarsi attuale in considerazione della sopravvenuta precarietà delle condizioni di salute e del più generale stato di decadimento fisico”. Che Riina sia pericoloso lo si può credere e sostenere; ma giudiziariamente parlando le affermazioni devono essere supportate da fatti e circostanze: non sono dogmi, atti di fede. La Cassazione chiede solo che le decisioni assunte dal Tribunale di sorveglianza siano motivate; perché solo così le si può accogliere.
La presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia Rosy Bindi, preoccupata che per il boss di Corleone si possano aprire le porte della cella parmense dove sconta i suoi pluri-ergastoli, si è subito precipitata in una non annunciata visita ispettiva. Ne ricava che Riina “è stato e rimane il capo di Cosa Nostra…perché capo rimane per le regole mafiose, non certo modificabili da quelle statali”; spiega poi che partecipa in videoconferenza alle numerose udienze dei processi che lo riguardano, e così dimostra “di conservare lucidità psichica e una certa capacità fisica”. Ed è “immutata la sua elevata pericolosità concreta e attuale, essendo in grado di intendere e volere, è interessato alle sue vicende processuali, è nelle piene condizioni di manifestare la sua volontà, e non ha mai esternato segno di ravvedimento”.
Riina, assicura Bindi, “gode di massima assistenza che gli permette di vivere una vita, e dunque, quando verrà, una morte dignitosa, a meno che non si voglia postulare l’esistenza di un diritto a morire fuori dal carcere non riconosciuto dalle leggi vigenti”.
Anche a rischio di essere accusati di imperdonabile candore (se va bene) o di quel tipo di complicità che si concreta nello scrivere quello che alla mafia piace sia scritto (ma giova avvertire: è tipo di accusa che scivola nella più gelida indifferenza: il catalogo degli improperi e degli insulti passati ci ha vaccinato a sufficienza), ci si permette di fare qualche osservazione.
La questione dello stato di salute la si liquida subito: per dichiarata e ammessa incompetenza. Lo dicano i sanitari qual è lo stato di salute di Riina. Quale che sia il loro verdetto non lo si discute.
La questione su cui invece si può azzardare qualche ragionamento è se Riina sia ancora il boss che è stato quand’era latitante. Per Bindi lo è, in base a una sorta di processo tautologico: lo è perché lo è.
Anche gli assiomi però devono seguire una logica. Riina è in carcere da 23 anni; sconta svariati ergastoli; è sottoposto al regime previsto dal 41-bis. Indubbiamente è un criminale feroce, spietato; comunque avanti con gli anni; è malato, sorvegliato anche quando va ad orinare…Ebbene la Cosa Nostra che è rimasta “fuori”, che continua, sia pure in misura ridotta rispetto ad altre organizzazioni criminali, a gestire loschi affari di ogni tipo, lo fa agli ordini di un personaggio del genere? Riina, insomma è tuttora in grado di comandare e imporre il suo volere; ed è un volere che chi è “fuori” accetta e riconosce? Se è questo quello che accade, bisognerebbe spiegare come sia possibile; è la certificazione del fallimento del 41-bis. E ci si deve anche chiedere come mai, da 23 anni, la Cosa Nostra “fuori” non ha saputo trovare una nuova leadership; perché accetti di ritenere e considerare Riina il boss dei boss, a cui tutto si deve e che tutto può…
La Cosa Nostra “fuori”, a questo è ridotta? Ma se Riina è ancora potente e al vertice dell’organizzazione, come mai abbiamo appreso (in virtù delle solite “confidenze” registrate, e poi fatte conoscere non da lui, ma dai magistrati), che si lamenta della scarsa considerazione che nei suoi confronti nutre il latitantissimo Matteo Messina Denaro, tutto preso a farsi gli affari suoi?
Che Riina sia colpevole di mille crimini e che sia giusto che sconti le pene per cui è stato condannato, non è in discussione. Ma si sostiene che immutata è la sua pericolosità. Perché è in grado “di intendere e volere”; perché è “interessato alle sue vicende processuali”; perché è “in condizione di manifestare la sua volontà”; infine perché non mostra segni di “ravvedimento”. Come dire: mostri meno interesse ai processi che lo riguardano, magari tenga sottomano una Bibbia, e forse risulterà meno pericoloso… Si sta celiando, è evidente. Ma non troppo: qualche cosa va chiarita. L’altro giorno il Giudice per le Indagini Preliminari ha archiviato la vicenda delle minacce di Riina a don Luigi Ciotti. Nell’ora d’aria il boss parlotta con un “nessuno” affiliato alla Sacra Corona Unita Riina sibila: “Ciotti, Ciotti, putissimo pure ammazzarlo”. E’ curioso che si lasci sfuggire simile confidenza senza timore di essere “ascoltato”; anche perché non è la prima volta che accade: altre volte si era abbandonato a “confidenze”, debitamente “ascoltate”. Ma senza addentrarci sulle ragioni che hanno indotto Riina a dire quello che ha detto, ora ci si limita alla decisione del GIP: come richiesto dalla Procura, archivia. Interessanti le motivazioni: pur avendo “la forza intimidatrice tipicamente mafiosa…erano destinate a rimanere prive di qualsivoglia potenziale rilevanza esterna…”. Quindi non hanno avuto la concreta possibilità di essere percepite dal sacerdote.
Quel “putissimo pure ammazzarlo”, va considerato un desiderio, un auspicio; ma “fuori”, ammesso che lo abbiamo raccolto, se la sono cavata con una scrollata di spalle. Del resto: chi dovrebbe mostrarsi sensibile ai voleri di “Totò u curto”? I seguaci e sodali di un tempo sono morti, o in carcere…
Interviene anche il presidente del Senato Pietro Grasso; esorta a non dimenticare “che Riina è ancora il capo di Cosa Nostra, e che la legge può dare la possibilità di interrompere il regime del 41 bis collaborando. Riina potrebbe ottenere la cessazione delle misure facendoci sapere chi erano queste persone importanti che lo hanno contattato prima di fare delle stragi”.
Qui il discorso si arricchisce di un nuovo elemento. Il 41-bis non si giustifica solo perché si vogliono ostacolare i contatti di particolari detenuti con le organizzazioni criminali che operano all’esterno. Il presidente Grasso dice che per chi “collabora”, questo regime può essere interrotto. E’ il principio della tortura: confessa, parla; e le tue carni non saranno più martoriate. Certamente il presidente Grasso è tutto meno che un inquisitore; certamente è nemico della tortura, in tutte le sue forme e manifestazioni. Nei suoi confronti si nutre stima, fiducia, simpatia. E tuttavia quel che fa intendere ha inequivocabile significato. Non solo: si indica anche in cosa deve consistere la “collaborazione”: far “sapere chi sono le persone importanti che lo hanno contattato prima di fare le stragi…”. Dovesse mai decidere di “collaborare” Riina sa già che cosa ci si attende da lui.
Lodevolissimo fine per carità. Qui, però torna utile ricordare il cosiddetto “metodo Falcone” per quel che riguarda i collaboratori di giustizia:
“Giovanni era solito ripetere…che si doveva tenere un comportamento tale da fargli innanzitutto percepire che davanti aveva un magistrato, un rappresentante di quello Stato che fino a un momento prima aveva visto come un nemico da combattere e che, da quel momento, doveva cercare di convincere della propria credibilità…e che non si doveva mai mostrare particolare interesse a un argomento o per taluni accusati: ciò per evitare di farsi strumentalizzare per fini diversi da quelli della ricerca della verità…”. La narrazione del “metodo Falcone” poi prosegue, e il presidente Grasso sa certamente a cosa ci si riferisce: i brani citati sono tratti dal suo recente “Storie di sangue, amici e fantasmi” (pagg.123-124).
Se dichiarazioni spontaneamente rese vanno prese con le molle, figuriamoci quelle carpite da microspie; e ancor più quelle microspiate a “saputa” del microspiato… Perché è di tutta evidenza che Riina ha parlato sapendo di essere ascoltato. Non solo: le sue infinite “confidenze” sono note da almeno tre anni: sono tornate d’attualità perché i faldoni con queste “confidenze” sono stati a acquisite e depositate dai magistrati che si occupano di quell’araba fenice che è la storia infinita rubricata come “trattativa”. Secondo i pubblici ministeri contribuiscono a consolidare il teorema accusatorio. Si vedrà con quale finale esito. Per ora i risultati non sono stati particolarmente brillanti. Di recente la sesta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale palermitana contro la sentenza assolutoria del 19 maggio 2016, e reso definitiva l’assoluzione dell’ex capo dei Ros, generale Mario Mori, e il colonnello dei carabinieri Mauro Obinu. Credo si possa dire che questa assoluzione mette una pietra tombale sull’impianto di questa ipotizzata vicenda: l’assoluzione per la mancata cattura di Bernardo Provenzano nel 1995 è una sorta di prova generale. Qualcosa la si poteva cogliere quando il procuratore generale Roberto Scarpinato, al termine della sua requisitoria, aveva derubricato il reato a favoreggiamento semplice, senza l’aggravante di mafia; di fatto uno “schiaffo” al Pubblico ministero Nino Di Matteo.
Dopo la “ribollita” Riina, eccone un’altra: Giuseppe Graviano. Affiliato alla cosca di Brancaccio, un ruolo di primo piano, con il fratello Filippo, nell’organizzazione delle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma, e nell’omicidio di don Pino Puglisi. Giuseppe e Filippo Graviano sono arrestati a Milano nel gennaio 1994. Svariati collaboratori di giustizia sostengono che è Giuseppe ad aver azionato il telecomando dell’autobomba che uccide Paolo Borsellino. Per mesi viene intercettato mentre si “confida” con un camorrista, ancora una volta durante l’ora d’aria. Migliaia di pagine di “sfoghi”, ma nulla sostanzialmente di nuovo, che già non si sapesse; soprattutto appare curioso che Graviano non sospettasse di una possibile intercettazione delle sue “confidenze”; e viene da chiedersi come personaggi ritenuti di tale spessore e “accortezza”, siano al tempo stesso capaci di simili “leggerezze”; se invece il sospetto di essere controllati l’avevano ci si deve chiedere perché si siano ugualmente “confidati”.
Come sia i pubblici ministeri sembrano dare a queste “confidenze” sapore di veridicità. Chissà… Comunque di queste cose si parla da tempo, e diffusamente; nelle corpose sentenze, per esempio, dei processi che si sono celebrati a Firenze per le cosiddette “stragi nel continente” (ne fa fede il formidabile archivio di “Radio Radicale”, che trasmette integralmente le udienze); inoltre esauriente sintesi la si può trovare nel recente “La strategia dell’inganno” di Stefania Limiti.
Al di là dei dubbi, delle perplessità: si ritorna all’uso (e talvolta abuso) dei collaboratori di giustizia: a quel “metodo Falcone” di cui sembra essersi smarrito ricordo e memoria.
Qualcuno senz’altro si ricorderà di Giuseppe Pellegritti, affiliato alla cosca degli Alleruzzo, e alleati del boss catanese Nitto Santapaola. Arrestato nel febbraio del 1986, una dozzina di omicidi alle spalle, si auto-accusa del delitto del giornalista Giuseppe Fava e sostiene di essere a conoscenza di fatti inediti sul ruolo giocato da Salvo Lima negli omicidi di Piersanti Mattarella e Pio La Torre. Falcone lo interroga e fiuta la polpetta avvelenata: negli atti depositati, spiega che Pellegritti non dice la verità. Dopo due mesi di ulteriori indagini Falcone appura la sua totale inaffidabilità, e firma un mandato di cattura per “calunnia continuata”.
Contro Falcone si scatena un’iradiddio; viene accusato di voler proteggere Andreotti e Lima. Durante una puntata della trasmissione Samarcanda, Leoluca Orlando lancia un’accusa gravissima: il pool ha una serie di omicidi eccellenti a Palermo e li tiene «chiusi dentro il cassetto». Alcuni esponenti del movimento “La Rete” (Carmine Mancuso, Alfredo Galasso, Orlando stesso), presentano un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura. Falcone viene convocato, per “discolparsi”, il 15 ottobre 1991; ecco quello che si può tra l’altro leggere nel verbale (il n. 61): “Se c’è stata preoccupazione, da parte nostra, è stata proprio quella di non confondere le indagini della magistratura nella guerra santa alla mafia…Non si può investire della cultura del sospetto tutto e tutti. La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, la cultura del sospetto è l’anticamera del komeinismo…Io sono in grado di resistere, ma altri colleghi un po’ meno. Io vorrei che vedeste che tipo di atmosfera c’è per adesso a Palermo…”. Ne è passato di tempo, da quel tempo. Ora, per dire, la presidente della commissione parlamentare antimafia Bindi pare abbia in animo di convocare, per un’audizione Giuseppe Graviano. Non avrà più bisogno di “confidarsi” durante l’ora d’aria; lo si potrà comodamente conoscere (omissis permettendo), ascoltandolo dai monitor della commissione; e se la seduta verrà secretata, si può esser certi che non mancheranno le “confidenze” di un commissario. Con buona pace del citato “metodo Falcone”: a parole da tanti preso ad esempio, nei fatti, da ben pochi applicato.