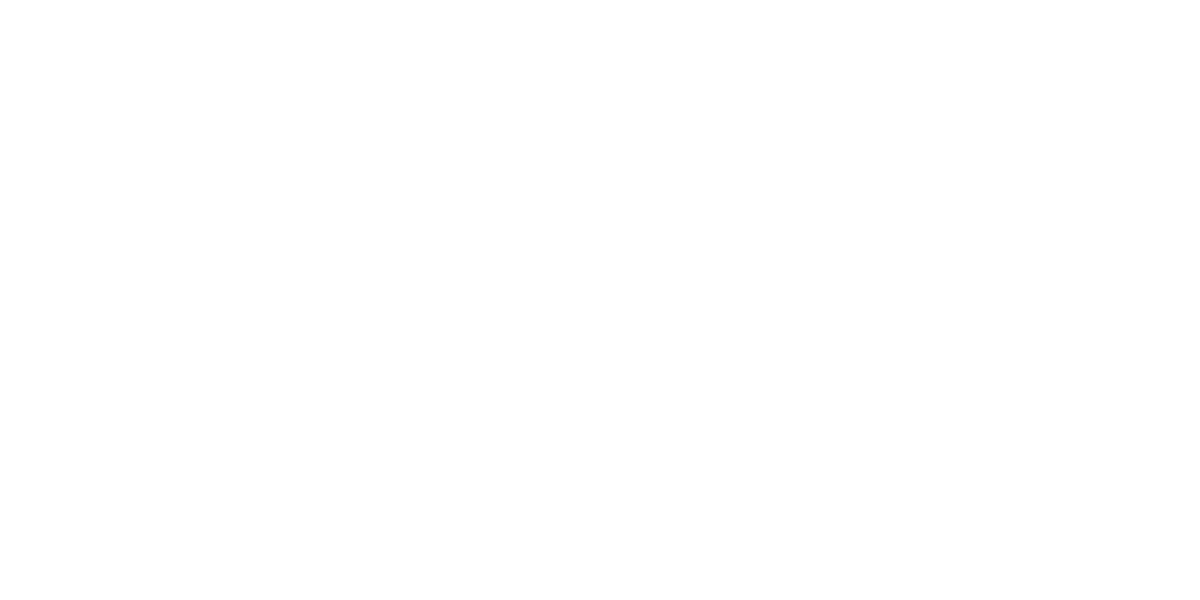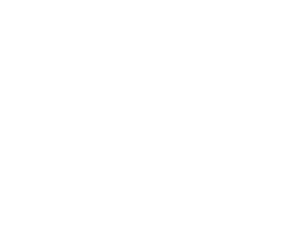Perché Pannunzio fu innanzitutto, affermiamo, un politico? Come nasce in lui – e come poi si dispiega compiutamente – la “forma” del politico?
Ripercorriamo il suo tragitto. Partiremo da una data, netta e ferma come uno spartiacque. E’ il 25 luglio 1943: esce l’“edizione di mezzogiorno” (dunque straordinaria) de “Il Messaggero”. Annuncia che il Maresciallo Badoglio è il nuovo Capo del Governo. Durante la notte è avvenuto il colpo di Stato, Mussolini è stato defenestrato dal Gran Consiglio, il Re ha (ri)preso in mano – sarà per un mese, all’incirca – la guida del Paese. Il giornale ha un solo foglio, anzi una sola facciata: le foto del Re e di Badoglio, i comunicati ufficiali, il secco avviso che Pio Perrone assume la direzione del quotidiano, il Bollettino di guerra – numero 1.156 – una appassionata cronaca della notte romana e delle manifestazioni che hanno avuto luogo, spontaneamente, al diffondersi della straordinaria notizia, e uno stringato editoriale. Forse una colonna e mezza, poche righe improvvisate a macchina, nella sede di Via del Tritone, da Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti, circondati dagli amici di sempre, Flaiano, Longanesi, Soldati. Sono quello che devono e non possono non essere: un appello alle “energie materiali e morali della Nazione” perché nell’ora “estremamente grave e perigliosa”, nel “momento della lotta, della disciplina e del lavoro”, si stringano attorno al Re, a Badoglio, all’Esercito. Ma c’è in esse già il tono del liberale, discepolo di Benedetto Croce. “Riacquistiamo oggi – vi si legge – la libertà di parola (…) che comporta tutte le altre libertà costituzionali e costituisce un elemento indispensabile alla vita come l’aria e la luce…”. Sentiamo l’eco della “religione della libertà”.
Pannunzio all’epoca faceva il regista muovendosi, in una delle personificazioni del suo stendhaliano romanzo di formazione, tra le opportunità che Roma, con i suoi vivaci ambienti artistici, culturali e politici, offriva. Era, pare assodato, tra i capofila riconosciuti di un manipolo di giovani ingegni effervescenti pronti a esplodere nella loro piena maturità espressiva – come in effetti avverrà nel dopoguerra – i quali variamente si occupano di arte, di letteratura e di cinema. Aveva collaborato, assieme ad Arrigo Benedetti, al longanesiano “Omnibus” e, sempre con Benedetti, diretto “Oggi”, un settimanale che è troppo definire di opposizione ma che era sicuramente un po’ più che frondista e che per questo il regime chiude nel 1941. In ore e tempi che si fanno sempre più inquieti e inquietanti, qualche puntata la fa anche sul terreno della politica. Sicuramente, in certi studi professionali, in certi salotti borghesi, si abbozzano i primi nuclei di cospirazione liberale, ed è tra questi che Pannunzio, il crociano attratto da Tocqueville, si aggira, già autorevole come nelle redazioni di periodici e giornali, al caffè Aragno o sui set di Cinecittà.
Quella notte, le righe battute a macchina, cambiano al giovane la prospettiva di vita. Molla il cinema, la regia, il giornalismo elegante e di successo. Diventa, semplicemente, il direttore di “Risorgimento Liberale”, la testata cavourriana inalberata dalle pattuglie che in quei giorni danno “ufficialmente” vita al Partito liberale italiano. Poi, l’8 settembre e l’occupazione tedesca. Pannunzio organizza un suo specifico reseau liberale antifascista. Rischia, viene arrestato, in carcere si salva dalle Fosse Ardeatine per uno stratagemma. E’ ora, sarà, un combattente, un “partigiano”. Un partigiano liberale e un politico: un radicale. Senza soluzione di continuità, fino alla seconda metà degli anni Sessanta, fin quasi alla sua morte, nel marzo 1968.
Il 4 giugno 1944 gli alleati arrivano a Roma, finisce l’emergenza dell’occupazione. Il giovane potrebbe tornare a girare la manovella del film malamente interrotto, potrebbe aspirare a un periodico di spicco. Invece no: resta a dirigere “Risorgimento Liberale”, che nel numero del 5 giugno reca un minuscolo box in neretto: “Il foglio che dal 1943 ha vissuto clandestino assume da oggi la forma ufficiale di periodico del Partito liberale italiano”. Tra la notte del 24 luglio 1943 e la notte del 4 giugno 1944 è nato qualcosa di più di un resistente. Si “nasce” così alla politica, alla grande politica, quella delle “passioni”: il titolo che aveva dato al suo saggio su Tocqueville. Pannunzio aveva trovato, si era trovato. Non tornò più indietro.
Apparentemente, è vero, Pannunzio non praticò la politica organizzata a tempo pieno e tanto meno i rivoluzionari di mestiere, le frequentazioni e i calcoli di partito o il partito come scelta di vita. Apparentemente. Ma subito, da queste settimane e mesi, dai primissimi anni delle grandi passioni liberali di e dei Mario Pannunzio – raccontati, ma ancor oggi restati sconosciuti, o misconosciuti – v’è subito una piena, sua e loro, singolarità forte, di destino, di destinazione, d’esistenza, civile, sociale, culturale che finirà, trasmessa, per divenire un connotato quasi inavvertibile, quasi etnico, antropologico, naturale, dell’homo radicalis, negli adattamenti che via via ne protrarranno la vita, la specie.
Il tripudio della Liberazione, dal fascismo, dall’occupazione tedesca, in quel 1944, fu grande, certo; ma non profondo, non duraturo, non segnò i volti dei più, dell’Italia liberata. Non espresse e non scelse una vera, attiva, fattiva soluzione di continuità con il paese dell’era e della forma fascista del passato recente, con il paese che non aveva e non ha conosciuto Riforma ma sempre Controriforme. Nessun grande affresco di sé produsse, né ce lo racconta oggi. Né il trionfante neorealismo ebbe o dette occhi e voce alla felicità per la libertà ritrovata.
L’entusiasmo profondo, duro e che non di rado si rivelò duraturo, era – fu – dei liberali, quelli. Comunisti e “progressisti” (come, e contro di loro, fascisti aggiornatisi e clericali di sempre) vissero e fecero vivere al paese quella Liberazione come parziale, illusoria; essendo la democrazia liberale e laica, “borghese” e “capitalista”, il vero nemico ancora da abbattere per far finalmente trionfare la redenzione e l’utopia della loro Città del Sole.
Fu l’anno del nuovo sacco di Roma, e di tutto il paese. I luoghi deputati o deputabili alla “politica”, cioè ai fasci e alle corporazioni, ai servizi sociali, alla cultura, alle arti e al dopolavoro, furono in un baleno requisiti, occupati, dai vincitori. Il patrimonio immenso, in primo luogo immobiliare, del perfetto monopartito fascista e corporativista, viene annesso e suddiviso fra famelici militanti e amministratori dei famelici partiti e dei famelici ideali di questo postfascismo. Cosa succede, cosa inizia a succedere? Lo Stato corporativista è un ordine immobile. E’ Stato etico, e ha la forma dell’immobilità, dell’etico, totale, perfetto (ciò che è etico è compiuto, non si articola…). Ma lo stato corporativista, appena crolla, diventa una veste a toppe da Arlecchino.
Maccheronicamente… “Et diviserunt vestimenta mea”. Ecco dunque i “luoghi” – e il luogo è anche forma – della “nuova” politica, del “nuovo” Stato antifascista. Questa appropriazione, questa continuità, questa “eredità”, ahinoi, non è soltanto materiale. Esplode il PNF e prendono luogo e forma tanti altri piccoli o grandi PNF, partiti dello Stato, del parastato, del lavoro, del dopolavoro. Ma i “luoghi” sono abitati. E, i loro abitanti, “nuovi” anch’essi – in quel momento – appaiono. Per breve tempo, illusoriamente. L’occupazione si prosegue in miriadi di piccole, private, altre occupazioni. A Roma oggi vivono ancora, da tre generazioni non di rado, i “nuovi” borghesi, i “nuovi” padroni, la “nuova” classe dirigente, dominante nel cammino fra quella ancora “parziale” Liberazione e la necessaria, promessa, Città del Sole. Vive, impera il nuovo potere.
Apparentemente… Pannunzio non amò, non praticò la vita militante, la vita di lotte generosa e spesso divorante, sempre drammatica del militante di partito, per il partito, per i grandi ideali, per la società intera, per eccetera. Ma a Pannunzio, ai Pannunzio non solo non s’aggiunsero nuovi averi, nuovi luoghi, nuovi strumenti, nuovo potere sia pur di lotta: gli ideali, le urgenze, il sapere, innanzitutto interiori, continuarono ad abitare, ad animare, ad affollare la loro quotidianità e le sue forme.
Ecco i liberali dei caffè, delle trattorie, della “Roma notturna”, dei modesti, quasi o spesso di dimensioni “private”, loro luoghi politici, editoriali, di dibattiti, di decisioni, di scelte: in una parola, di lotta. “Risorgimento Liberale” in una parte modesta della sede de “Il Giornale d’Italia”, a Palazzo Sciarra; le sedi de “Il Mondo” in non più di 120 metri quadri a Via Campomarzio e poco più a Via Colonna Antonina; al piano di sopra la sede “nazionale”, “centrale” del Partito Radicale: tutto affittato a prezzi di mercato. E le abitazioni, di Pannunzio in Via Cola di Rienzo, di Ernesto Rossi a Piazza Stefano Iacini – come quasi tutte le altre – modeste e restate le stesse in quei decenni.
Così Mario Pannunzio, i Pannunzio si iscrivevano, si iscrissero nel loro e nel nostro tempo, e in modo indiscusso. Prestigiosi per le élites, ma tenuti e condannati alla inesistenza, alla clandestinità, nel loro paese e fra la loro gente.
Torniamo al ’45 – ’46, torniamo alla Liberazione. Torniamo alla scelta di vita per la quale il brillante, giovane intellettuale “romano” si è già fatto il carcere nella Resistenza, s’è salvato miracolosamente dalle Fosse Ardeatine e si trova ora a essere praticante della sua e loro religione della libertà, un praticante che con naturalezza, spontaneità inavvertita, entra nella lotta senza le armi delle quali gli altri partiti e militanti s’erano appropriati; inerme, francescano oseremmo dire, suscitando probabilmente il suo incredulo e ironico sorriso, o, per passare in territorio e storia umbra, capitiniano, gandhiano (e qui il sorriso diventerebbe riso, fors’anche, nel suo pudore estremo, schivante e riconoscente).
Oh, il signore, i signori di Rosati, di Via Veneto, con gli Arrigo Benedetti e gli Ennio Flaiano, i Vitaliano Brancati e gli Eugenio Scalfari, i Mino Maccari, gli Amerigo Bartoli e i Giorgio Vigolo, gli Alessandro Bonsanti e Attilio Riccio, i Carlo Antoni e i Carlo Laurenzi e le Giulia Massari, e poi i Ciccio Libonati, i Panfilo Gentile, e il sempre immanente Mario Ferrara… Qui con lui, attorno a lui: “Se non ci conoscete, guardateci i calzini, noi siamo i radicali del Conte Carandini”; e lontanissimo – certo – Pier Paolo, che passa poi vent’anni a cercare di correggere o censurare la felice invettiva che ci scagliò contro (e chi qui scrive supplicò invano di restaurarla fedelmente, rispetto a una infedele vulgata): “…schiavi della norma e del capitale”. Ma Pannunzio aveva e accresceva sempre di più il tempo del dialogo su un versante dall’apparenza altrettanto “diversa”, fra calvinista e aristocratico, con Niccolò Carandini, Leone Cattani, Chinchino Compagna, Vittorio De Caprariis… E poi – dimenticavo – la rete, il sistema immateriale, di continua navigazione quasi internettista, intensa, per tutta l’Italia; mille nomi, sicché non ne facciamo neanche uno solo: pensiamo, con geografiche e umane puntualità, al Piemonte e alla Lombardia, ai Veneti e all’Emilia, alla Toscana, a Napoli, a Bari, alla Sicilia e alla Sardegna. E a noi “giovani” dell’UGI e dell’Unuri, della (Giovane) Sinistra Liberale. Rispetto al giovane improvvisato resistente che rischia e incontra il carcere antifascista, sembra lontanissimo il doppiopetto grigio di questo Direttore che appare lì, installato nei caffè, nella quasi mondanità di piccoli ozi borghesi, così estraneo ai rivoluzionari professionisti, agli intellettuali impegnati, alla politica e ai partiti che contano. Mario Pannunzio, è noto, riceve e legge i giornali a letto, alle 9, al risveglio, dopo aver fatto le ore piccole in via Veneto o anche a piazza del Popolo. Ma, ricordiamolo, all’elenco – parzialissimo – dei nomi delle sue giornate abituali che abbiamo evocato, s’aggiungono, sempre, l’universo politico dei La Malfa, dei Saragat – degli Altiero Spinelli, a tratti – degli esponenti “laici”, oltre che liberali: repubblicani, socialdemocratici; e, ben presto, la simbiosi travolgente, connotante da sola tutti gli anni 50, con l’altro… diciamolo: gigante di questa storia pannunziana, crociana, salveminiana (aggiungiamo: einaudiana), l’Ernesto, Ernesto Rossi. Quale altra storia, quale storia altra non viene a confluire qui, con quella di Mario Pannunzio! Noi sentiamo d’esser stati e d’essere attraversati, forse tuttora trainati, dalla grande corrente di pensiero, di opera, di profezia, di moralità civile straordinaria, che sembra sorgere dal momento della loro congiunzione e dal crearsi di questa loro storia che ci pare divenire unica. Certo, più che mai – oggi – storia d’altri tempi: preghiamo che siano futuri.
Ma interrompiamo l’elencazione dei nomi, dei giorni, di questa parte così grande della vita del Mario Pannunzio, di quello “nostro” quantomeno. Le ore, le opere, i giorni nella redazione, nel partito, nell’otium e nelle pratiche, contengono tutte una tale tremenda intensità e quantità, di fatti, di fatti che restano, duri come pietre, come cose, non biodegradate. Dettano, questi fatti pannunziani, il da fare, li avvertiamo come linfa che ci raggiunge ma che è difficile, anche se debito, non dissipare.
Le due notti del 24/25 luglio ’43 e del 4/5 giugno ’44 marcano, manifestano l’affermarsi – in e da Mario Pannunzio – della sua scelta, la grande politica delle passioni che egli stesso ci aveva rivelato facendone la cifra della lettura di Tocqueville, nel saggio della sua piena giovinezza. Lì nasce e da allora vive il resistente, il partigiano liberale, il grande politico, il radicale. Quelle notti sono dunque luce per leggere vent’anni italiani, vent’anni pannunziani. Ma, anche, ci portano a un’altra notte, quella della solitudine, della rassegnazione, della sconfitta e “morte” di Mario Pannunzio. Fino ad allora, non avrà mai cessato di inventare, trovare, creare in diffuse forme di quotidianità, banali e banalizzanti perfino nel senso comune, le forme della lotta e dei successi nella aspra, lunga (sempiterna, per un liberale) via da percorrere per giungere a radicare ed edificare riforme e l’essenza della libertà in questo paese. Accadde, accade che un vivere troppo drammatico, difficile, combattuto nella giungla priva di regole dell’antidemocrazia postfascista, generi letali ferite interiori e rovesci nell’intimo e nella propria casa e famiglia – come colpe proprie, o dell’uno o dell’altro – la violenza della contraddizione che ci venne, ci viene, dall’esterno portata. Così la fine della vita comune di Ernesto Rossi e Mario Pannunzio, esplosa da un dissenso che apparirebbe oggi di pretestuosa gravità, non significò, come troppi ebbero bisogno di affrettarsi a decretare, la fine del Partito, e della storia pannunziane, radicali, ma – questa sì – quella de “Il Mondo”, del luogo, della sede anche, del Partito e della politica radicale inventata, governata da Mario Pannunzio. Altri però non credettero o non accettarono quella morte; poco dopo, ricordo, con alcuni mormorammo: “Quando noi morti ci destiamo”…
Mario Pannunzio nulla aveva accumulato di forza, di potere materiale politico-partitocratico italiano. D’un tratto, dopo 20 anni disperò di potere ancora e di nuovo fare del suo corpo, della sua coscienza, delle sue abitudini, dei suoi “salotti” (ma quali?!) il luogo più d’ogni altro adeguato, o quantomeno sufficiente per continuare la sua lotta partigiana radicale. Ma, come se davvero esistesse e operasse un Dna politico, altri – tanti altri – furono pannunziani almeno in questo: che continuarono indefessi a ricreare, reinventare, dando loro corpo e poc’altro, poc’altro, i luoghi, le ragioni, gli ideali della politica, i riti pur essi inevitabili della laica religione della libertà. Pasolini – che strano, non direste? – comprese quanto, come, modeste sedi redazionali o di partito, i bar e i caffè, i marciapiedi, i “luoghi bui” e malfamati della città, le carceri, le prostitute, i fascisti, il tentare la parola con i piedi, marciando, con le terga dei sit-in, con i bavagli, con il magrore dei corpi, con la spoglia forza delle nudità, costituissero alternativa alle sedi tradizionali della politica, del sociale: il possibile nuovo luogo, i nuovi luoghi della Riforma, da guadagnare contro le mille Controriforme che hanno dissestato e dissestano, non solo idrogeologicamente, questo paese.
Avevamo iniziato a scrivere queste pagine – e voglio qui ringraziare profondamente il Presidente Casini (allora presidente della Camera, ndr) per questo onore e anche, mi si creda, questo onere per me gravi – impegnandoci a tentare di rispondere ad alcuni interrogativi: “Perché Pannunzio fu innanzitutto un politico? Come nasce in lui e come si dispiega compiutamente la “forma” del politico?”
Insomma: Pannunzio fu innanzitutto il giornalista o il politico? Rispondiamo ora che Pannunzio fu il centro di un sistema, di un sistema straordinariamente e durevolmente politico, di un sistema costruito con mirabile, umilissima, molto poco evidente opera quotidiana per creare raccordi, comprensioni, intese, superamento di storie particolari, fondendole, forgiandole nel calore di una visione, di una volontà politica ed ideale liberale, radicale. Che la sua militanza politica attraversò oltre 20 anni della storia italiana e della sua vita, pur se assolutamente tuttora non vista, negata, esclusa da quasi tutti: è stata ed è questa una necessità per fare della storia radicale, di Mario Pannunzio, la tomba di una verità, la verità di una sorta di etnia malgré-soi che carsicamente percorre il sottosuolo della nostra politica e del paese, irriducibile a presenza e attore marginali.
Il sistema-Pannunzio, da lui sicuramente, lentamente, incessantemente, costruito, rafforzato, allargato, assorbendo e annettendo sistemi minori ma non minimi, è tale da condurre al suo centro una sempre maggiore e migliore quantità e qualità di raggi.
Aggregazioni da un territorio cosparso di solitudini, di centri e di grumi, testimonianza, lascito, presenza del mondo azionista, di quelli democratico nittiano, cattolico-modernista, cattolico-murriano e sturziano, cattolico-liberale della realtà risorgimentale, di quello dell’umanesimo “cristiano”, siloniano. Una ancor più ampia intellettualità “non impegnata” viene perfino tesserata, nel Partito Radicale al cui centro, come nelle testate giornalistiche, è Mario con Ernesto.
Qui, ad ora, nulla della documentazione acquisita meritoriamente dalla Camera dei deputati consente a chicchessia di rivendicare o d’escludere eredità pannunziane. Per decenni ormai i radicali di oggi sono stati attenti e intenti a non rivendicarle, “appropriandosene”. Sappiamo solo che da oltre tre decenni, specie nelle Sedi ufficiali della politica e delle istituzioni ufficiali, ci siamo applicati a evocare, scandire – perché le trascrizioni nei verbali fossero corrette! – i nomi che furono e sono anche quelli della vita reale, della lunga, grande lotta e resistenza partigiana della libertà di Mario Pannunzio – e il suo.
Sono trascorsi 35 anni da quel marzo 1968 della sua dipartita, quando, al massimo in poche centinaia, pretendevamo di costruire, di continuare la storia del Partito Radicale. Allora, anche il semplice sospetto di alimentare le scarsissime possibilità di riuscirci (o la grande probabilità di fallire) appropriandoci della memoria di Mario e di Ernesto, ci gravava addosso e dentro come pericolo di iniquità e anche di menzogna.
Oggi, dobbiamo e possiamo assumerci la responsabilità di questa durata, di un connotato grande e certo della storia di questo nostro paese. Partigiano, clandestino, estraneo ai palazzi d’Italia; ma non, certo, alla sua gente: ignorare, censurare questo fatto, ancor peggio che sbagliato sarebbe inutile. Ma non c’è davvero motivo, in questa sede e in questa occasione che tutti dobbiamo alla Camera dei deputati, per omettere, non affermare il dovere e la felicità di quella pietas erga lares che Pannunzio merita dall’intero paese e, almeno per questo, da noi, radicali di oggi e del mondo. De “Il Mondo”?
Fonte: Il Foglio